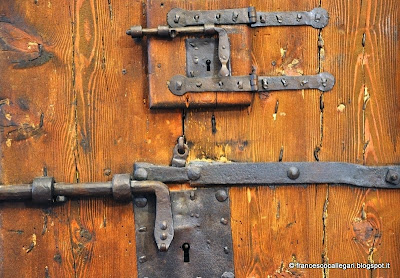|
N |
ella
difficile situazione attuale, ciascuno di voi sta cercando di fare il meglio
possibile per mantenere il contatto con i nostri allievi. Allo stesso tempo, è
necessario rendersi conto che le procedure a distanza che stiamo adottando
vengono attuate senza un necessario periodo di sperimentazione. Questo ci
obbliga a tarare continuamente le modalità e i carichi di lavoro legati alle
nostre proposte didattiche.
E
sottolineo la parola DIDATTICHE, in quanto desidero evidenziare che il nostro
essere docenti si compone di tanto e tanto altro. Mi riferisco a tutto ciò che
vivete ogni giorno in classe, soprattutto alla parte relazionale che, in questa
situazione, potrebbe essere limitata o addirittura compromessa. Bastasse
mandare compiti per mail o creare lezioni su piattaforme o su YouTube, non
saremmo più così indispensabili.
Consapevoli
di ciò, vi prego di considerare questo periodo anche alla luce delle difficoltà
che le famiglie stanno vivendo: tanti genitori vanno al lavoro e i figli sono
affidati a nonni, parenti, vicini di casa, amici.... Non possiamo pertanto
pretendere che tutti i nostri ragazzi siano accompagnati dai loro genitori con
gli strumenti informatici per un tempo lungo e a qualsiasi ora del giorno.
Diverse famiglie, oltretutto, sono sprovviste di adeguata attrezzatura.
La
situazione è legata a un’emergenza che impedisce o limita fortemente la vita
regolare delle famiglie, sconvolgendo quei ritmi che ci servirebbero per
garantire un buon rendimento scolastico. E di questo dobbiamo tenere conto.
Vi
esorto a non farvi prendere dall'ansia nello svolgimento di quello che, ormai
tanti anni fa, era il "programma" e che, adesso più che mai, diventa
serena progettazione legata alla contingenza del momento.
Penso
sia importante che rassereniate i vostri allievi con la vostra presenza
virtuale, supportandoli in tutti i modi che riteniate opportuni in
considerazione della profonda conoscenza che avete di loro.
Vi
invito a utilizzare gli strumenti informatici a distanza anche e soprattutto
per accompagnare i vostri ragazzi in un momento così delicato della loro
esperienza di vita: aiutate i vostri allievi a fare tesoro di quanto stanno
vivendo, rammentiamo loro il valore della solidarietà, la riscoperta dei
semplici gesti e i comportamenti normali. Tutte cose che, speriamo quanto
prima, possiamo tornare ad accogliere come un dono di cui essere grati.